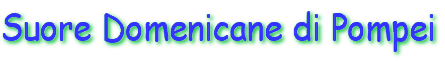Date da non dimenticare
*Date da non dimenticare *1887: In onore a San Giuseppe *24.05.1891: Consacrazione del Santuario *05.05.1901: Inaugurazione Facciata del Santuario *Il Monumento alla Pace Universale *50.mo Anniversario del Santuario *23.04.1965: Paolo VI incoronò Maria *07.05.1987: Centenario dell'Incoronazione della Vergine del Rosario *1997: Inaugurazione della Cappella di San Giuseppe Moscato *01.10.2022/01.10.2023: Cammino Giubilare Longhiano

*1887 - In Onore a San Giuseppe
Un Artista per Pompei
La tela era stata commissionata dal Vescovo e dal clero di Bergamo con l’intento di offrirla in dono al Papa Leone XIII nella ricorrenza del suo giubileo sacerdotale (1887). Il dipinto, portato a Roma, riscosse lusinghieri consensi nell’ambito della Curia, meritando così di figurare nell’Esposizione Vaticana del 1888.
Bartolo Longo in quella occasione ebbe l’opportunità di ammirare l’opera ricevendone un’impressione profonda. Quel "carattere spirituale e devoto" trasfuso nella figura della Santa, suscitava intensa commozione.
Il Maestro, senza mezzi troppi appariscenti e con lo studio profondo dei particolari, era riuscito ad assurgere ad un felice concetto, esprimendo tutta la santità della scena, piena di dolcezza e di mistico e puro senso di tristezza.
Un artista per il Santuario
Bartolo Longo aveva scoperto finalmente l’artista che desiderava lavorasse per il Santuario a Valle di Pompei.
Risoluto gli spedì una lettera da cui chiari traspaiono i suoi desideri e le sue emozioni: "Al Signor Ponziano Loverini, Pittore. Borgo S. Caterina – Bergamo. Chiarissimo Signore, vidi un suo quadro all’esposizione Vaticana, Santa Grata con Sant’Alessandro e fui invaghito dal suo stile e dalle sue concezioni nell’arte. Dissi tra me: l’opera di questo pittore non deve mancare nel santuario Monumentale di Pompei, che è una mostra dell’arte italiana cristiana moderna di fronte alle vestigia dell’arte pagana antica.
Io non ho il bene di conoscerla di persona, né conosco le sue esigenze nei lavori di pittura. Però se ella pensasse, nel suo cuore, come tanti artisti italiani e stranieri hanno inteso un desiderio di visitare quest’opera di religione, di arte e di civiltà che sorge rimpetto all’antica Pompei, sarei ben lieto di comunicarle i miei sentimenti, e, col viso della voce, potremmo accordarci per qualche dipinto, che, usufruendo il lustro di questo Santuario, renderebbe mondiale anche il suo nome. Intanto per farle avere qualche breve ragguaglio di quest’opera che la Provvidenza ha affidato alle mie cure, le mando alcuni quaderni del mio Periodico ed una immagine della nostra Vergine del Rosario. Sono, con profondo ossequio, suo devotissimo Bartolo Longo".
L’incontro con il pittore Loverini fu provvidenziale; Bartolo Longo aveva piena ed urgente necessità di un artista cristiano a cui poter commettere le pale per gli altari che andava man mano erigendo nel novello Tempio dedicato alla Vergine del Santo Rosario. L’occasione gli si offriva propizia per l’erezione dell’altare di S. Giuseppe.
Non conosciamo, purtroppo, la risposta del Loverini alla lettere così lusinghieri di Bartolo Longo.
Sappiamo, però, che l’Avvocato il 29 maggio del 1889 rinnovò l’invito all’artista con termini veramente affettuosi: "Venite a passare qualche giorno a Pompei, facendomi il più grande dei favori. Resterà a mio conto la spesa per il viaggio e starete con noi in quei giorni come persona di famiglia" (B.L.)
La tela e l’altare di San Giuseppe
Il pittore, irretito da un invito così suadente, assicura di essere a Pompei il 24 luglio del 1889.
In quell’incontro Bartolo Longo dovette esporre al Loverini i suoi progetti inerenti i dipinti da sistemare sugli altari e, più di tutto, discussero sicuramente circa la tela rappresentante il transito di San Giuseppe da esporre sull’altare nella grande cappella, a destra della Crociera. Indubbiamente ci fu l’accordo e la commissione, lo apprendiamo da una lettera del Loverini da cui stralciamo: "Bergamo, 7 settembre 1889. Illustrissimo Signor Avvocato, ieri ricevetti la sua gentilissima lettera contenente un vaglia di lire 1.000. A tanta attenzione non posso che ringraziarla immensamente assicurandola che il quadro da lei commessomi: il Transito di S. Giuseppe, convenuto alla somma di lire 5.000, lo consegnerò infallibilmente il 15 aprile 1890".
Il quadro, infatti, spedito puntualmente, giunse per ferrovia, alla stazione di Scafati il 14 aprile 1890; per il trasporto Bartolo Longo pagò 73 lire e 25 centesimi. La grande tela fu sistemata su telaio dal Signor Chiariello "valente costruttore di tele" mentre, "l’artista Pesce, ne ricavò una magnifica fotografia".
Installato il dipinto, rapidamente fu ultimata la magnifica struttura dell’altare e del cappellone. Il 7 maggio, mercoledì del 1890, il Cardinale Guglielmo Sanfelice dei Duchi di Acquavella alle ore 12 benedisse la cappella e consacrò solennemente l’altare.
"Questo altare sebbene non importante quanto quello dell’abside, ne ricorda tuttavia le linee principali ed è degno di osservazioni perché ne risulta un insieme artistico ed altamente religioso.
Un marmo rosso sanguigno (Griotta di Cannes) ne forma l’orditura principale, alternandosi nei fondi con durissime stalattiti di abbagliante fosforescenza.
Nei Capi Altare, invece, i fondi sono di raro marmo multicolore (Serrangolino). Due magnifiche colonnine di marmo nero (breccia africana), calzate da basi attiche con i fregi di bronzo dorato, simili a quelle dei capitelli, sorreggono la mensa che è tutta di un pezzo.
Il Ciborio presenta sul suo fronte un pronato con colonne di stalattiti dalle basi e dai capitelli di bronzo dorato. La trabeazione e la cornice sono di un vivissimo marmo rosso (breccia). La porta e la parte interna del Ciborio sono di bronzo dorato, lavorato con grande finezza.
La predella col sottostante scalino (marmo grigio dei Pirenei) forma base all’altare e si accorda perfettamente con esso.
L’altare è fornito di un parato di candelieri di bronzo massiccio dorato, che, sebbene più piccoli, riproducono nel disegno quelli dell’altare maggiore.
A destra dell’altare è addossata al basamento di un pilastro la mensola per deporvi le ampolline. Essa è composta da una lastra di raro marmo giallo (giallo di Siena) e di una gran mensola scolpita (marmo bianco di Carrara)" (Bartolo Longo).
Abbiamo ritenuto utile riportare l’antica descrizione dell’altare per fornire elementi convenienti per un paragone storico.
Si ricordi che a seguito dell’ampliamento del Santuario (1934-1939), furono affiancate al primitivo corpo centrale del Tempio le due navate laterali. Durante la costruzione di esse fu inevitabile, per validi motivi tecnici e strutturali, modificare notevolmente la linea architettonica originaria sacrificando, in parte, anche il sontuoso rivestimento marmoreo dei due altari del braccio destro e sinistro della crociera.
Bartolo Longo nel Periodico di luglio del 1890 esultante scrive:
"Il Transito di San Giuseppe del Professore Ponziano Loverini: una nuova gloria dell’arte italiana che trae le sue ispirazioni dall’ideale religioso.
L’Artista doveva incarnare un soggetto che va annoverato tra i più sublimi della storia della religione soprannaturale, e che si reputa il più difficoltoso dà grandi artisti.
Come abbiamo notato, la scena non è umana soltanto, ma umana e sovrumana ad un tempo.
I personaggi sono tre, tutti e tre offrono un grado di eccellenza che diventa ineffabile sotto il punto di vista dei rapporti che li uniscono nel compimento di una missione altissima.
Da una parte l’Uomo-Dio, dall’altra Maria e Giuseppe. L’Uomo-Dio entra in relazione sensibile con questi due esseri umani con il rapporto domestico e giuridico di figlio.
Maria, pur riconoscendo la sua inferiorità di natura a Gesù, è madre, e ne esercita il ministero.
Nella morte di San Giuseppe il Loverini, presentando i tre personaggi della scena tradizionale: (il protagonista che sta esalando lo spirito a Dio, la Vergine Santissima e il Divin Figliuolo che assistono), ha saputo con la fantasia variarla in modo nuovo e bello rischiarando la rustica camera del falegname di Nazareth con la luce che viene dal Cielo, e popolando l’aria di angeli lontani, di due che stanno sopra il moribondo con palme e di altri tre inginocchiati al suo fianco destro.
Così, un fatto del tutto conforme alla comune sorte dei mortali, prende carattere ascetico ed entra nei campi del sovrumano, dell’ideale.
(Da: Il Rosario e La Nuova Pompei – Anno 107 – n° 1 – Gennaio/Febbraio 1991)
(Autore: Nicola Avellino)
La prodigiosa Immagine del Rosario resterà esposta nella nuova Chiesa sino alla Domenica 13 del Mese (1). Ed in quella Domenica per la prima volta in Pompei del Novello Santuario di Maria, accorreranno i poveri contadini ad onorare lo Sposo Immacolato dell’Immacolata Madre di Dio, il Patrono della Chiesa Universale (2), il Protettore della Chiesa di Pompei, e della nuova Casa del Rosario, e della buona morte (3), il Patrono della Chiesa Universale. I Contadini faranno la Comunione Generale, e vi sarà solennizzata la Prima Comunione dei fanciulli e delle fanciulle assidui al Catechismo. Ed il chiarissimo Missionario apostolico Sac. D. Francesco Scardaccione di Napoli farà il Colloquio della Comunione Generale ed il fervorino nella Benedizione di Gesù Sacramentato. Precederà la festa un triduo di Prediche, che farà il P. Maestro Fra Alberto Radente (4) dei Predicatori nominato dal Vescovo di Nola a Rettore della nuova Chiesa del Rosario in Pompei. La Festa sarà tutta di beneficenza e tutta a spese di alcune dame Napoletane devotissime del Santo Patriarca. Si darà il vestito ed il pranzo ad un vecchio, ad un fanciullo e ad una donna poveri (5), in onore della triade Terrestre. Si distribuiranno tre vestiti di premio a 3 fanciulli più assidui e più diligenti del catechismo festivo, ed altri 3 abiti alle fanciulle, ed un maritaggio di L. 50 (6). Si darà l’elemosina a 15 poveri in onore dei 15 Misteri. E il giorno vi sarà detto il panegirico, dal chiarissimo Oratore Domenicano P. Lettore F. Vincenzo Guida di Napoli.
Note
(1) I nostri lettori già sanno; più volte l’abbiamo riportato ed in varie occasioni abbiamo precisato che il Quadro miracoloso della Vergine, nei primordi dell’Opera Pompeiana, fu collocato provvisoriamente e per breve tempo nella vecchia e cadente chiesuola del SS. Salvatore in attesa di essere custodito ed esposto alla venerazione, nella cappella del SS. Rosario ubicato in un piccolo ambiente sulla sinistra per chi entra nell’attuale Santuario. In attesa che si completassero i lavori per la costruzione del grande Tempio e, soprattutto, dell’altare monumentale con il suo trono grandioso, le funzioni si svolgeranno appunto in quella piccola Cappella con naturale disagio per i fedeli, tutti desiderosi di prostrarsi ai piedi della Vergine miracolosa ed implorare da Lei ogni grazia.
Bartolo Longo addirittura fu costretto, specialmente per i pellegrinaggi con numerosi partecipanti, a stabilire un turno di prenotazione al fine di poter consentire a tutti di venerare, anche per breve tempo, più da vicino la Sacra Immagine. In qualche ricorrenza solenne, sempre compatibilmente con lo svolgimento dei lavori, il Quadro veniva trasferito nel Tempio in costruzione e collocato su un altare centrale, provvisorio, contornato da altri cinque altari più piccoli per dare agio ai numerosi sacerdoti di celebrare la Messa ed ai fedeli di raccogliersi in preghiera. Nel 1883, come Bartolo Longo ci testimonia. Il Quadro fu esposto infatti nell’erigendo del Tempio "occupato per metà da anditi; e stuccatori, e marmolai, e pittori, che già intendono a decorare la parte più eccelsa della Chiesa quale è la Cupola, ed i quattro archi maggiori, secondo le regole della buona architettura.
Pertanto i pellegrini entreranno dalla porta maggiore del Tempio, ascolteranno la Messa all’altare a bella posta eretto nel mezzo di esso per venerare l’immagine prodigiosa" (B.L.).
(2) Il Papa Pio IX, con proprio decreto del giorno 8 Dicembre 1870, aveva solennemente dichiarato San Giuseppe Protettore della Chiesa Universale.
(3) Bartolo Longo aveva fondato la Confraternita per gli agonizzanti ed aveva predisposto una speciale schiera di candide orfanelle, chiamate appunto Giuseppine, deputate a recitare particolari fervide preghiere per gli associati moribondi "soccorrendoli in quelle ore angosciose ed estremo bisogno con la prece potentissima dell’innocenza" (B.L.).
Il primo associato alla Confraternita fu proprio Leone XIII che, per felice coincidenza, morì il 20 luglio 1903, il giorno del Transito del Patriarca San Giuseppe da secoli celebrato dalla Chiesa e, per la prima volta, in quell’anno, commemorato e festeggiato nella Basilica di Pompei.
(4) Bartolo Longo profondamente commosso partecipa ai fratelli e alle sorelle del Terz’ordine della Penitenza di San Domenico, la morte del Padre Radente, il loro direttore. "Il nostro dolce, benigno e caritatevole Direttore, padre maestro Fr. Alberto Radente dei Predicatori, il vero sacerdote secondo il cuore di Dio, il degno rappresentante di San Domenico in mezzo a noi suoi figli, il primo Apostolo del Rosario in questa Valle di Pompei, il sottile filosofico, il profondo teologo, l’inarrivabile maestro di spirito, colui che possedette in grado eroico le virtù dell’umiltà, della carità, del disinteresse, della purità, della misericordia, della povertà e della obbedienza religiosa, il tenerissimo amante di Maria, venne a noi rapito da questa terra di esilio il giorno di lunedì 5 di gennaio (1885), nell’ora dei primi vespri dell’Epifania, lasciando noi tutti nel pianto e nell’amarezza… I suoi esempi ed eminenti virtù, le sue massime di una semplice ed insieme alta santità siano vive innanzi agli occhi nostri ed alla nostra mente" (B.L.).
Per inciso si ricordi che la memoria di Padre Radente, in relazione all’Opera Pompeiana, deve restare imperitura e, senza limiti, la riconoscenza. Egli aveva dato alla sua penitente, Suor Maria Concetta De Litala, la vecchia e sdrucita tela della Madonna del Rosario; su indicazione di Padre Radente, Bartolo Longo si recò da quella pia monaca e ne ebbe in dono il quadro che, portato a Valle di Pompei, fu esposto alla venerazione per la prima volta la sera di sabato, 13 Novembre 1875.
(5) Con l’istituzione dell’Ospizio per i figli dei carcerati (1892), la beneficenza ai poveri ed ai fanciulli veniva effettuata da Bartolo Longo in un ambito notevolmente più vasto. La cerimonia del pranzo si svolgeva infatti nel cortile dell’Istituto ed era una offerta simbolica, un piacevole dono fatto dai giovinetti ivi ricoverati, quasi a voler essi offrire un ringraziamento; un ricambio di carità, anzi, una sublime trasformazione: i beneficiati diventavano benefattori. Sul calendario del 1904, Bartolo Longo pubblicò la cerimonia del pranzo offerto il 24 maggio q903 a 100 vecchietti ed ai fanciulli poveri. È una pagina stupenda, la riproduciamo con qualche doloroso taglio.
"Quale caratteristica sfilata! Vecchi e fanciulli indossano abiti puliti, camicie di bucato, e forse in quel mattino avevano curata un poco più attentamente degli altri giorni la personale nettezza. Entravano, uno per volta, sotto il porticato, dove erano ordinate le mense. Tra i vecchi, chi zoppicava, chi poggiavansi su due bastoni; altri trascinavansi innanzi con movenze stentate, altri poggiavansi alla spalla del compagno vicino; qualche infelice, perché cieco, era condotto per mano, i fanciulli, invece, irruppero come un’ondata. Tutti portavano al collo, sospeso con un nastrino, il biglietto di invito fatto a forma di cuore.
Ogni povero aveva innanzi, al proprio posto, il suo tovagliolo, una bottiglia di vino, un mezzo pane bianchissimo, il piatto, il bicchiere e la posata. I Figli dei Carcerati nella loro tenuta di gala si affaccendavano intorno alle tavole; e dalle sale, che mettevano capo nella grande cucina dell’Ospizio, sino alle mense era una processione di fumiganti tondini pieni di saporose e odorose vivande. Era grazioso vedere i fanciulli poveri che sgranavano tanto d’occhi all’arrivo di una grossa porzione di carne. I vecchi guardavano di preferenza le bottiglie, e vi fu pure chi cedette qualche pietanza in cambio del vino, al compagno. Ma la festa raggiunse il massimo brio, quando comparvero delle grosse torte dolci. I Fanciulli invitati, con gioia infantile, applaudirono, seguendo con gli occhi ogni porzione che veniva staccata dal piatto comune e servita per turno. Negli occhi dei vecchi tremolavano lagrime di riconoscenza, i monelli vociando e ridendo erano soddisfatti delle ore passate in tavola. Come ricordo della bella Festa furono donati ai centro poverelli i piatti, la posata, il bicchiere, la tovaglia e il tovagliolo che avevano usati per il pranzo".
(6) Maritaggio: istituto giuridico consistente nell’assegnazione di una somma di denaro o altro bene a titolo di dote per consentire di contrarre un matrimonio, socialmente decoroso, anche a donne non appartenenti a famiglia con adeguati mezzi economici. La somma destinata al maritaggio era di lire cinquanta ed assegnata ad una giovinetta bisognosa e meritevole tratta a sorte tra quelle che avessero raggiunto il quindicesimo anno di età ed a condizione che avessero frequentato l’Oratorio festivo con assiduità e per almeno quattro anni; dovevano, inoltre, aver serbato una condotta di vita lodevole come si conviene ad una fanciulla "educata alla scuola di Gesù Cristo e che abbia fatto profitto nel Catechismo" (B.L.).
Il premio toccato alla prescelta dalla sorte, veniva posto su di un libretto della Cassa di Risparmio e consegnato alla intestataria, con i rispettivi frutti maturati, al compimento del ventiquattresimo anno di età. (Autore: Nicola Avellino)
*24.05.1891 - Nel deserto Pompeiano si consacra il Santuario
*1901 - Un Monumento alla Pace Universale
"Mentre gli statisti discutono, i congressisti si radunano, i governanti si impensieriscono, i pietosi sperano, le popolazioni si immiseriscono e le campagne mancano di agricoltori, in Valle di Pompei abbiamo già eretto un Monumento attestante il desiderio dei popoli, la preghiera dei credenti e l’aspettativa di quel bene sociale tanto desiderato ed invocato: la Pace. E sotto gli occhi di tutti è sorto, a testimonianza del desiderio di tutti, il Monumento di arte e di fede, la Facciata del Santuari, attestante il plebiscito dei poveri e dei ricchi per la Pace Universale".
Lo scritto di Bartolo Longo è del marzo 1901 e conserva, purtroppo ancora intatta, la sua cocente attualità. Abbiamo letto il bel passo per ricordare il movente di un’opera insigne in cui l’arte, la fede, la carità e la fraternità si congiungono in perfetta armonia per significare nella pietra il sospiro e la preghiera di ogni uomo per la pace universale.
Il Santuario era nato infatti come opera di fede e di carità: un prestigioso disegno con la mira principale di affratellare gli uomini di ogni razza, di ogni colore, di ogni lingua. Cominciato con l’obolo umile di pochi fedeli, si portava a compimento con l’offerta, spesso generosa, del mondo intero. La Cina, l’India, le Americhe, l’Europa, in special modo, avevano concorso alla edificazione di un’opera di così vaste proporzioni: uomini di origini e di culture le più disparate, avevano univocamente aderito ad un programma che inneggiava alla fratellanza, alla carità, alla pace.
Già nel Febbraio del 1886, dalle pagine del periodico Il Rosario e la Nuova Pompei, Bartolo Longo aveva levato la sua voce suadente invocando il concorso per un’opera religiosa e sociale e ne aveva fatta propaganda in tutto il mondo, con l’intento di ottenere il consenso e l’offerta universale, da spendersi per il Monumento della Pace Universale.
La prima pietra fu collocata il 15 maggio 1893, lunedì, alle ore 10,30. Il rito fu presieduto dal Cardinale Raffaele Monaco La Valletta, decano del Sacro Collegio assistito dai Vescovi delle diocesi limitrofe e dal numeroso Clero Pompeiano.
Alla presenza di una folla immensa di fedeli in preghiera, la prima pietra della nuova e grandiosa facciata del Santuario, fu benedetta e rinchiusa in una teca di marmo pregiato. Nella stessa teca si collocarono tre monete e tre medaglie della Vergine di Pompei, una pergamena che recava scritti i nomi di Bartolo Longo e della Contessa sua Consorte, del Cardinale Monaco la Valletta e di tutti i sacerdoti addetti al Santuario. Il simbolico involucro fu calato nelle viscere della terra come a rappresentare il fertile seme di un’opera tanto ardimentosa. Per un anno e sette mesi, cioè fino a tutto il 1894, si lavorò entro terra per le fondazioni che, per la natura geologica del sottosuolo, la minacciosa vicinanza del Vesuvio e per le pesanti moli di pietra da sovrapporre, esigevano più tempo, perizia, diligenza, e soprattutto, spese ingenti. Ai primi del 1895 si pose mano alla costruzione della parte visibile (fuori terra) della facciata; il lavoro, condotto con alacrità, si protrasse fino al 14 marzo 1901. In quel giorno si installò, al vertice del timpano, l’effige della Madonna e l’opera, davvero grandiosa, poteva considerarsi compiuta.
La statua, alta metri 3.25, rappresenta la Vergine del Rosario in piedi; sulla sua base di marmo aggettante, secondo l’antico desiderio del Vescovo di Nola, Mons. Giuseppe Formisano, si sarebbe dovuto scrivere a grandi lettere di bronzo: "Non nobis, Domine, non nobis; sed nomini tuo da gloriam" (Non a noi, non a noi, ma al tuo nome dà la gloria).
Bartolo Longo per ispirata disobbedienza, fece incastonate, invece, su quel marmo, la parola PAX. E lo fece con profonda convinzione. Più tardi, infatti, scriverà risoluto: "Il mio testamento è questo: vi lascio la pace". Un giovane napoletano, lo scultore Gaetano Chiaramonte, appena uscito dalla scuola della R. Accademia delle Belle Arti di Napoli "l’aveva levata dal marmo": un colossale monolito di Carrara, bianchissimo. Don Bartolo non tralasciò l’occasione per creare una cerimonia significante: la benedizione della statua della Vergine prima che fosse issata sul fastigio della facciata. "Con questa benedizione che cosa intendiamo fare? Noi col benedire questo marmo, che è l’effige della Vergine, della Regina di questa Valle, benediciamo anche gli operai che per 25 anni hanno spese le loro fatiche; i benefattori di tutto il mondo, tutti quelli che ci hanno dato modo per compiere l’opera che Dio affidava al vostro e nostro cuore. È compiuto il Monumento glorioso che porterà ai secoli venturi la memoria e l’attestato indelebile e imperituro della nostra fede e della nostra carità" (B. Longo)
*07.05.1939 - 50.mo Anniversario del Santuario
"Nel 1934 ho iniziato a lavorare, quale scalpellino in architettura, nella Basilica di Pompei, fino al 1939. Ho trattato pietre provenienti da tutto il mondo: dal Belgio, dalla Francia, dall’Australia, dal Canada, dalla Russia, da Trani, da Carrara e dal Piemonte con il suo granito cipollino o rosso".
Dinanzi allo straordinario, crescente, - forse anche inatteso nella consistenza – coinvolgimento dei fedeli, dinanzi all’interesse del mondo per Pompei, l’originario disegno del luogo di preghiera formulato da B. Longo si rivelava ormai inadeguato, insufficiente: di qui il dilemma se optare per una nuova Chiesa o ampliare quella già officiante. Non si trattava, infatti, di semplice problema di spazio, ma anche di rispetto verso l’esistente, e cioè verso quella struttura eretta da B. Longo e consacrata nel 1891, che era costata sudore, sacrifici, impegni, entrata a far parte ormai della memoria della marianità del popolo, costituita oggi dalla navata centrale fino alla crociera.
Prevalse così la seconda ipotesi: l’architetto archepito fi Mons. Spirito Chiappetta, delegato espressamente dal Vaticano. "Con me, prosegue Marino Machetti, hanno lavorato i geometri Rossi e Bellone, proveniente quest’ultimo da Milano, c’erano Masto Michele (Capo ferraiolo), l’assistente Giardini, che curava la muratura ed Erminio, che curava la carpenteria, c’era Pietro Vitiello che ha fornito puzzolame, breccia, arena e che trasportava tutto il materiale con traini e carrette".
Dietro tutto questo, il Prelato Mons. Anastasio Rossi, Patriarca con la sua fermezza, la piena consapevolezza di dover dare alla preghiera del Rosario e della Supplica un’atmosfera di più ampio respiro, più preziosa persino nei particolari, generosa nei marmi delle colonne, nelle pitture. "I meravigliosi affreschi dell’abside, della cupola e di quant’altro pertinente la lunghezza della Basilica, furono eseguiti in gran parte dall’emerito pittore prof. Landi.
È il prof. G. Clemente che parla con i suoi ricordi, la voce emozionata dei suoi 78 anni. I tempi di attesa i pompeiani li trascorrevano seguendo le trasformazioni che i lavori creavano nel monumento, mentre raccoglievano e ricevevano i contributi che la Provvidenza non aveva mai lesinato. Dall’inizio dei lavori, il 2 ottobre 1933 ultimo dei 15 sabati in preparazione alla festa del S. Rosario, alla consacrazione del 6 maggio 1939, sarebbero passati quasi 6 anni.
"La nuova Chiesa che viene a coprire una superficie di circa 2.000 metri quadrati è cinque volte più grande della precedente che misurava solo 421 mq. La cupola si spingeva a soli 29 metri di altezza, mentre l’attuale innalza la sua croce a 57 metri dalla piazza"; è quanto si legge in una monografia del 6 maggio 1939, quando il Cardinale Luigi Miglione, segretario di Stato di Pio XI, il Papa dei progetti arditi, compie la consacrazione.
Dalle pagine del periodico, nel numero maggio/giugno 1939, parte lòa descrizione del grande avvenimento, ripreso, peraltro, dai giornali del tempo, diffuso radiofonicamente. Si trattò di un momento edificante, perché l'ampliamento del’a Basilica, al di là della sua valenza erchitettonica e della sua preziosità estetica, costituiva la prova tangibile che il messaggio mariano affacciatosi quasi immediatamente nella realtà locale, per essere ascoltato aveva richiesto una casa più grande, un maggior numero di confessionali, una schiera più fitta di nsacerdoti per celebrare, per ascoltare, per diffondere la parola di Dio. Si trattava del miracolo della preghiera, dell’arte, dell’ascolto, della generosità, tutti aspetti che a dieci lustri di distanza si inseriscono in una realtà mariana immutata nello spirito, anche se al passo con i tempi.
Il tempio che lo stesso Fondatore, il Beato Bartolo Longo († 1926), aveva costruito dal 1876, posa della prima pietra, al 1891, si era rivelato insufficiente ad accogliere i devoti che a migliaia affluivano a Pompei. Si rendeva necessaria una soluzione.
All’ipotesi di un nuovo Santuario, si preferì, per ragioni affettive, procedere all’ampliamento di quello già esistente.
Il progetto dell’architetto, sac. Spirito M. Chiappetta, conciliò le varie esigenze. Occorsero sei anni di duro lavoro (1934-1939), ma i risultati furono estremamente lusinghieri. Il 7 maggio 1939, il nuovo tempio fu consacrato e dedicato da Sua Eminenza il Cardinale Luigi Maglione, Segretario di Stato di Pio XII.
Cinquant’anni, da allora, sono trascorsi e milioni di pellegrini e visitatori hanno con diversità di accenti espresso il loro amore alla vergine ed hanno imparato, guidati da Lei, ad essere "pietre vive" dell’edificio spirituale che è la Chiesa di Cristo.
È quanto ha voluto sottolineare il Cardinale Opilio Rossi, Presidente della Commissione cardinalizia per i Santuari di Loreto, Bari e Pompei, intervenuto alla celebrazione dell’anniversario: "Quello dunque che noi ammiriamo qui costruito materialmente deve richiamarci ad una ben più alta realtà, che pulsa all’interno dell’anima nostra; quello che vediamo qui fatto con pietre, deve avvenire, mediante la divina grazia, nei nostri cuori.
Dobbiamo essere consapevoli di appartenere all’unica Chiesa di Cristo e di sentire di conseguenza il dovere di essere pietre viventi sviluppando in noi quelle virtù che ci qualificano veri cristiani di fronte al mondo, forti nella fede, consolidati nella speranza, compaginati nella carità.
Saremo così pietre inserite nel mirabile edificio di Dio, di cui questa nostra sontuosa basilica è immagine".
*23.04.1965: 50.mo Incoronazione - Paolo VI, il Papa che incoronò Maria
È il 23 aprile 1965 quando Papa Paolo VI presiedette, nella Basilica di San Pietro, la Messa per l’incoronazione dell’effigie della Madonna di Pompei: Il 19 febbraio precedente, era giunto, all’Istituto di restauro del Vaticano, il Quadro della Vergine, da cui i devoti si erano "staccati" non senza dispiacere. Ma il tempo aveva inferto alla tela le sue inevitabili ferite e quel viaggio era indispensabile a porvi rimedio.
Il Santo Padre tenne, in quella storica celebrazione, cui partecipò un numero straordinario di fedeli, provenienti non solo dalla Campania e guidati dall’allora Arcivescovo Prelato, Monsignor Aurelio Signora, un’omelia meravigliosa, intrisa della profonda cultura fi Papa Montini.
Parole non prive di afflato poetico. "Ci commuove il fatto, che ora devotamente compiremo, - disse nel "plurale maiestatis" dell’epoca – di dovere noi stessi, con mani tremanti, rimettere sulle sacre effigie di Gesù e di Maria, le preziose corone, che la vostra pietà e la vostra generosità, servite da arte squisita, vogliono espressione simbolica del sommo onore dovuto a Cristo, e per suo riflesso alla sua santissima Madre".
Un Papa, il vicario di Cristo sulla terra, che, rispetto alla Madonna, ha "mani tremanti" d’emozione. Ma il ritorno alla bellezza dell’opera d’arte doveva portare ad un’ancor più profonda conoscenza e devozione per la Madonna. "Come il restauro di questo quadro mette in limpida evidenza le sembianze della Vergine, così il restauro della nozione che noi abbiamo di Maria ci deve portare ad una più nitida, più vera, più profonda conoscenza di lei, quale la sacra Scrittura, la Tradizione, la dottrina dei santi e dei Maestri della Chiesa ci hanno delicatamente delineata".
Nel suo discorso, Paolo VI ricordò anche la figura del fondatore, il Servo di Dio Bartolo Longo (che in seguito sarà beatificato da San Giovanni Paolo II il 26 ottobre 1980) e tornò con la memoria ad una sua esperienza personale.
Nell’aprile del 1907, quando aveva appena nove anni, aveva infatti visitato la Basilica della Beata Vergine con i suoi familiari, insieme ai quali aveva pregato dinanzi al trono di Maria.
Quel Quadro sarà riportato a Pompei in processione, attraversando, tra ali di folla, alcuni quartieri di Napoli ed altre città della Campania: San Giovanni a Teduccio, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata.
"Il Rosario e la Nuova Pompei", il periodico del Santuario, parlerà di "festa di paradiso". È anche per questo che l’annuncio della canonizzazione di Paolo VI, resa nota da Papa Francesco durante il concistoro del 19 maggio scorso, è stata accolta con gioia dai devoti della Madonna di Pompei.
(Autore: Giuseppe Pecorelli)
E Papa Montini con "mani tremanti" incoronò la Vergine
Cinquant’anni fa il Quadro della Madonna di Pompei fu incoronato dal Beato Paolo VI. Era il 23 aprile 1965. Il ritorno a Pompei dell’Icona venerata, che da Napoli attraversò i comuni costieri, fu una vera festa di popolo. Ecco i ricordi di Mons. Pietro Caggiano, testimone diretto di quei giorni rimasti nella storia.
È sempre bello ed utile ricordare i compleanni o gli anniversari che, grazie a loro memoria, danno senso anche al futuro. Con piacere riferisco alcuni episodi ed informazioni sull’eccezionale evento riguardante la nostra Icona.
Era il 1965 ed ero sacerdote solo da tre anni, quando si rese necessario il restauro della venerata Immagine. È ben noto che le opere d’arte, ai fini di una buona e lunga conservazione, hanno bisogno di cura e ordinaria manutenzione. Il quadro della Madonna del Rosario fu donato a Bartolo Longo, fondatore del Santuario, nel novembre 1875. Non era in buone condizioni, d’altra parte era stato dipinto circa duecento anni prima ed aveva subito i contraccolpi di un trasporto malagevole durante le missioni popolari dei domenicani dell’Italia del Sud. Quando l’avvocato Longo ricevette il Quadro da Suor Maria Concetta De Litala ebbe da esclamare: "Ohimè! Provai una stretta al cuore al primo vederlo. Era non solo una vecchia e logora tela, ma il viso della Madonna, meglio che di una Vergine benigna, tutta santità e grazia, pareva piuttosto quello di un donnone ruvido e rozzo. Chi mai dipinse questo quadro? Misericordia!". Giunto a Pompei, l’Immagine fu oggetto di una pulizia superficiale ed, in seguito, nel maggio 1879, di un restauro accurato ad opera del pittore Federico Maldarelli.
Nel corso degli anni si moltiplicarono i devoti, sia italiani sia stranieri, che donavano ex voto "per grazia ricevuta". Oggetti d’ogni genere segno di devozione. Alcuni tra i più pregiati furono letteralmente appesi alla Tela, ma il loro peso indebolì o ruppe alcuni fili del tessuto, provocando la caduta di parte della pittura. L’umidità ed il calore del clima locale, invece, influirono nel deterioramento dei colori. Si giunse così al 1965 quando si rese assolutamente necessario un restauro radicale. L’Arcivescovo Aurelio Signora, allora Prelato di Pompei, scrisse a Papa Paolo VI implorando l’intervento di tecnici vaticani, che ne garantissero la qualità e la veloce esecuzione dei lavori. Si voleva così evitare la lunga assenza dell’Icona durante le visite dei fedeli. Ne seguì un’operazione molto delicata per il valore religioso e storico del Dipinto. Le tre fasi essenziali si svolsero alla presenza di Don Mario Pinzuti, monaco olivetano, direttore dell’Istituto di Restauro Vaticano. Furono rimossi "i preziosi" catalogandoli uno ad uno: un adeguato servizio fotografico documentò la condizione del Quadro prima e dopo i lavori. Seguì l’imballaggio ed il trasporto in Vaticano sotto scorta ed, infine, dal 19 febbraio al 20 aprile, fu realizzato il restauro tecnico. Mi impressionò l’attenzione e devozione di coloro che partecipavano, con le più disparate mansioni, all’esecuzione del progetto per il migliore risultato.
Il direttore chiuse così la relazione: "Dopo tale ritocco la venerata Immagine; riacquistato il primitivo aspetto, è tornata alla sua bellezza artistica, senza nulla perdere della tradizione devozionale acquisita". Questo fu il terzo restauro, effettuato a 90 anni dall’arrivo della Tela a Pompei. Va ricordato che nel 2012, per iniziativa dell’Arcivescovo Carlo Liberati, l’Immagine è stata mirabilmente restaurata nei laboratori dei Musei Vaticani.
Sin dall’origine, nel Quadro, la nostra Madonna e Gesù hanno sul capo le rispettive corone d’oro, simbolo della regalità spirituale. Dopo il restauro sembrò naturale la sostituzione delle antiche corone con altre nuove, più adeguate alla sobria presentazione dell’Icona, avendo rimossi la maggior parte dei gioielli. Papa Paolo VI, che aveva approvato e facilitato il restauro e si era costantemente informato sul suo evolversi, volle vedere le corone prima di compiere il rito dell’incoronazione. Fu per me un’esperienza indimenticabile aver partecipato alla loro custodia nel corso dei vari trasporti.
La sera del 21 Aprile il Quadro fu collocato nella Basilica di San Pietro sul trono preparato per la speciale occasione. Seguirono due giorni d’intensa venerazione da parte di migliaia di romani e di pellegrini provenienti dalla Campania. Il 23, alla presenza di cardinali, vescovi, sacerdoti, religiosi e laici, il Santo Padre celebrò la Santa Messa ed il solenne rito dell’Incoronazione.
Alle ore 14 si partì dal sagrato della Basilica di San Pietro ed alle 15, sotto una "benedetta pioggerellina", si giunse all’Ospedale San Giovanni dove gli ammalati, a nome di tutti i sofferenti dell’Urbe, diedero il saluto all’Immagine diretta alla Cattedrale di Napoli, dove si vegliò in preghiera e canti tutta la notte. Il 24, nel primo pomeriggio, si avviò il "ritorno a casa" attraversando, come avvenne per la prima volta il 13 Novembre 1875, le vie della città costiere. Dovunque una folla incalcolabile, orante ed osannante, salutava l’Icona su di un carro addobbato a festa con fiori e drappi di velluto e seta.
I pompieri diedero il benvenuto alla Madre con le tradizionali luminarie e i fuochi d’artificio, che squarciarono l’oscurità della notte. All’epoca non mancavano alcune voci, che mal interpretando il Concilio Vaticano II, consigliarono di non eccedere nell’entusiasmo della devozione mariana per "non interferire con il nascente Ecumenismo". Ma la Madre attrasse i suoi figli: furono tremila le persone che parteciparono all’incoronazione per mano di Paolo VI e che "riaccompagnarono" il Quadro a Pompei.
Questo trionfo terreno mi fa pensare ad alcune parole di Bartolo Longo, a commento del quinto mistero della Gloria: "O Regina bellissima, io non pretendo di vederti in terra, ma voglio venire a vederti in Paradiso; e Tu me l’hai da ottenere (…). Ma Tu trionfa finalmente di questa anima a te dedicata, e come tua serva fedeli la proteggi, la difendi dagli assalti de’ suoi nemici, la copri sotto il tuo bel manto, ne rendo felice la morte e beata l’eternità. Così spero, e così sia".
(Da: Il Rosario e la Nuova Pompei di maggio 2015 – Autore: Pietro Caggiano)
*07 Maggio 1987: Centenario dell'Incoronazione della Vergine del Rosario
Un secolo di devozione mariana
La visita del Segretario di Stato al Comune di Pompei
Maggio 1987: la città di Pompei riceve il Cardinale Agostino Casaroli, inviato da Papa Giovanni II, come suo Legato, per il Centenario dell’Incoronazione della Vergine del Rosario, in risposta all’invito ricevuto, di persona, dal Prelato Mons. Domenico Vacchiano. Nel maggio del 1887, la nascente Pompei accoglieva il Cardinale Raffaele Monaco La Valletta. Il Legato che Leone XIII inviava nella Valle di Pompei, rispondendo così all’invito rivoltogli dall’Avv. Bartolo Longo e dalla Contessa De Fusco, durante l’udienza ad essi accordata il 14 aprile di quello stesso anno.
Gli eventi si rincorrono e nella sostanza esprimono il percorso della città nel suo nascere, nel suo divenire, nel suo rimanete legata all’antica e nel suo proiettarsi nel futuro. Così, il 7 maggio, il Legato del Pontefice, Segretario di Stato, Card. Casaroli è stato ufficialmente ricevuto dal Sindaco nella sala consiliare di Palazzo De Fusco, accompagnato Domenico Vacchiano, Vescovo-Prelato di Pompei, dal Nunzio Apostolico in Italia S. E. Luigi Poggi e dal Vescovo Mons. Zama.
Un secolo di storia
Cento anni or sono la folla era diversa: c’erano gli indigeni, i fedeli dei paesi vicini, l’aristocrazia napoletana, i rosarianti che si spostavano dalle diverse città d’Italia, dall’Europa. Erano persone che vivevano i problemi e la fede del loro tempo e avvertivano l’esigenza di pregare. È quello che accade anche adesso, in un mondo nel quale il progresso ed il pluralismo delle idee sono la caratteristica più evidente.
"Se per sommo beneficio di Dio Onnipotente… la sacra Immagine della Vergine di Pompei, venne incoronata, a nome del Romano Pontefice, da un suo Legato, anche oggi, con lo stesso ardore e con la stessa devozione vogliamo anche noi, che ne siamo i Successori, non solo ricordare il fatto, ma espressamente vogliamo siano oggetto di speciale celebrazione, sia il titolo sia anche il luogo e ciò diciamo, perché vengano esaltati insieme alla Vergine di Pompei il santo Rosario e il suo glorioso Santuario… Proprio per questo abbiamo pensato a Te, Venerabile Fratello, ad essere il nostro Personale Legato, nel presiedere alle solenni celebrazioni che, in occasione della Supplica del prossimo 8 maggio il Santuario suole organizzare… Sia una celebrazione che ricordi e ravvivi quel primitivo fervore che, auspice il Beato Bartolo Longo, segnò l’inizio della sua opera caritativa e sollievo e istruzione degli orfani…".
Con questo messaggio personale Giovanni Paolo II ha affidato al Cardinale Casaroli l’incarico di essere a Pompei: è lo stesso Pontefice che ha pubblicato l’Enciclica "Maria Madre del Redentore", che ha proclamato Beato Bartolo Longo; è quel Pontefice che, avverando la profezia di Don Bartolo, è venuto a visitare il Santuario Mariano affacciandosi dal balcone della Basilica, benedicendo i presenti, i lontani, i giovani delle Opere sociali, i sofferenti, accorsi per vederlo. Il messaggio porta la data del 13 aprile 1987 e, straordinariamente, ci riporta al 14 aprile del 1887, quando Leone XIII, ricevendo Bartolo Longo, gli annunciava che sarebbe stato presente a Pompei per l’incoronazione di Maria nella persona del Cardinale La Valletta.
La partecipazione dei pellegrini
Per questo la Supplica di quest’anno centenario ha assunto un significato particolare, anche se nulla è stato toccato nel susseguirsi della celebrazione: nelle ore dell’antivigilia, infatti, prima della discesa del quadro, la città si è andata via via popolando soprattutto da parte dei gruppi di fedeli che giungevano a piedi, recitando il Rosario, intercalando i quindici misteri con canti rivolti alla Vergine. Uno spettacolo antico e nuovo, presente anche ora che esiste la possibilità di raggiungere la città più comodante, con mezzi motorizzati pubblici o privati.
Dinanzi al quadro sfilato, si soffermano, pregano persone di ogni ceto e di ogni età durante il giorno, durante la notte: rivive in questo andirivieni lo stesso tipo di risposta che Bartolo Longo ricevette in occasione della incoronazione della Vergine, per un’ora di guardia. Era una guardia d’onore, che doveva compiersi con la recita delle quindici poste del Rosario: "Per tal modo, egli scriveva, in tutta la vigilia del gran trionfo di Maria, questa Cappella sarà trasformata in un Paradiso…".
L’appello viene idealmente accolto ad allora, anche in pieno secolo ventesimo, nell’era del computer e delle conquiste stellari. Esso viene espresso nel raccoglimento, nella devozione, nella commozione, nello stupore dell’essere in tanti, nella fede e nella pietà, mentre si attende il giorno dopo; quando le stesse persone si sono ritrovate, il Cardinale Agostino Casaroli, il Nunzio Apostolico per l’Italia S. E. Luigi Poggi, il Vescovo Vacchiano, il Vescovo di Castellammare di Stabia, il clero, le orfanelle, gli orfani delle Opere, tutti insieme, la notte fra il 7 e l’8 maggio, davanti a Maria.
L’Omelia del Cardinale Casaroli
E si giunge alla concelebrazione eucaristica nella legittima attesa dell’omelia e della recita della Supplica.
L’Omelia viene pronunciata dal Legato Pontificio: dal racconto "incantevole" del Vangelo secondo Luca, il Presule ci ha condotto a Nazareth "il borgo sonnacchioso", dove la gente badava alle proprie faccende "nasceva, moriva, soffriva, si allietava". Qui, a Nazareth, nella "pienezza del tempo" sarebbe giunto il Messaggero a visitare la Vergine "che aveva trovato grazia presso Dio", alla quale avrebbe annunciato la misteriosa quanto sublime maternità. "Eccomi", avrebbe risposto Maria, e pronunciando questo "fiat" avrebbe dato inizio al mistero della Redenzione, di un altro "fiat" altrettanto provvidenziale, nella gioia, come nel dolore, nella morte e nella resurrezione.
"Col Rosario nella mano, Bartolo Longo – ha detto il Cardinale Casaroli -, risvegliò le coscienze dei contadini della Valle, oppressi dalla miseria… trasformò in una terra di risurrezione e di vita una terra di morti… Anche per noi Cristo, e con Lui la sua Madre, restano al centro della storia umana, e della nostra…
Se questo tempio è grandioso monumento di fede intrepida, le Opere che lo circondano sono frutto dell’amore, che della fede è il fiore più bello. Una corona alla vergine, esse sono, non meno preziosa – certo – di quello che, cento anni fa, esattamente, un altro Legato del Pontefice Romano, il Card. Monaco La Valletta, posava sul capo dell’Effige della Madre del Salvatore e del suo Figlio divino. Oggi noi commemoriamo solennemente quell’evento… e ripetiamo, rivolti a Maria: e tu copri con il manto della tua onnipotenza supplichevole la chiesa…; il Papa che è presente qui, oggi, davanti alla tua effige venerata, nell’umile persona del suo Legato; il mondo e l’Italia…".
Da ogni parte, ma concittadini della stessa città
Tutto questo è esplicito ed implicito nella Pompei Mariana: preghiera e carità, un connubio molto prezioso, che assume in sé il senso della giustizia e la regalità dell’amore, che esprime "un secolo di devozione, un secolo di prodigi". E, infatti, tenendo conto di questo connubio fra civiltà, carità e giustizia che tutta la città vive gli eventi della religione e della religiosità sul piano civile: il popolo di Pompei ha mostrato la sua riconoscenza al Legato Pontificio, non solo, ma ha espresso anche il voto di mantenersi degno del Fondatore della città, creando un clima umano e cristiano, dove le diverse civiltà trovano possibilità di coesistenza e di progresso. Si tratta di procedere all’unisono, nei contenuti operativi, con "l’estensione geografica nella quale il popolo cristiano con fede e devozione cerca vivamente di aprire il cuore per un incontro con la Madre di Dio"; si tratta di ripetere il grazie delle nuove generazioni a Bartolo Longo ed a quanti gli furono accanto nella costruzione spirituale e materiale di Pompei; si tratta di rendere omaggio ai Pontefici che da allora continuano a guardare con occhio attento al Santuario; si tratta di riconoscere alle autorità civili il senso di responsabilità che hanno verso questo aspetto della città; si tratta, ancora di essere tutti coinvolti, ed attivamente, in un disegno provvidenziale vissuto quotidianamente, nella assiduità miracolosa dell’amore verso il prossimo.
Il momento della recita della Supplica rientra in questo grande disegno: esso coinvolge il residente abituale, l’uomo della strada, il visitatore italiano e straniero, dal tedesco al giapponese, all’americano e richiama, contemporaneamente, come è accaduto quest’anno, personalità della cultura, della politica, come il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, On. Antonio Gava, il Prefetto di Napoli, Dott. Agatino Neri, il Sen. Francesco Patriarca, l’On. Carmine Mensorio, e altri ancora, che si mischiano fra la folla e non si distinguono più, nel nome della Vergine del Rosario e del Santuario.
(Da: Il Rosario e la Nuova Pompei di luglio e agosto 1987 – Autore: Luigi Leone)
*1997: Inaugurazione della cappella di San Giuseppe Moscati
L’Associazione dei Medici Volontari San Giuseppe Moscati ha dato inizio alle sue attività culturali con una conferenza sulla figura di "Giuseppe Moscati: medico e Santo", tenuta dal Prof Dott. Luca Steardo, docente presso la facoltà di Medicina dell’Università di Bari, uno dei fondatori dell’Associazione.
La conferenza ha avuto luogo il 22 dicembre 1997, nell’ambito dell’inaugurazione, benedizione e dedicazione a San Giuseppe Moscati di una nuova cappella nel Santuario di Pompei, presiedute dall’Arcivescovo Mons. Toppi.
La cerimonia è avvenuta alla presenza di numerose autorità, tra cui: Mons. Cece, Vescovo della diocesi di Castellammare, il Prof. G. Donsì, Rettore dell’Università di Salerno, il Prof. R. Pasquino e il Prof. F. De Simone, Presidi rispettivamente della facoltà di Ingegneria e di Farmacia dell’Università di Salerno, il G. Uff. Gen. U. Ianniello dell’O.E.S.S.G. e il Prof. Sandro Staiano, Sindaco di Pompei.
Spinta dalla presenza dell’Associazione nelle Opere di Pompei, Mons. Toppi, ha inteso interpretare un’aspettativa largamente diffusa tra i fedeli e dare testimonianza di una profonda devozione verso questo laico Santo dei nostri giorni, che nella pratica della sua professione seppe in maniera impareggiabile profendere, accanto ai frutti di un altissimo sapere scientifico, luce di fede e ardore di carità.
"Decisione questa particolarmente attesa e da tutti sentita opportuna" – ha sottolineato il Prof. Steardo – "soprattutto se si considerano i rapporti di caritatevole servizio che Moscati intrattenne con le Opere di Pompei. Difatti egli volle prestare come volontario, con la gratuità dell’atto d’amore più autentico, la propria opera di medico a quanti, in qualunque modo, appartenessero alle Opere".
Il relatore ha poi rimarcato come Moscati fosse stato capace di superare limiti della visione dell’uomo del suo tempo. Egli "si formò in un ambiente culturale in cui si operavano i primi tentativi di riduzionismo biologico che desacralizzava la vita e imprigionava l’uomo in schemi classificatori ponendolo alla sommità della scala evolutiva, ma privandolo di ogni dignità di trascendenza. Egli seppe sfidare queste concezioni vivendo costantemente l’impegno di medico che riconosce in Dio l’origine della vita e il suo destino ultimo".
Il Prof. Steardo ha poi continuato ricordando le tappe salienti della carriera accademica e ospedaliera di Moscati, rimarcandone l’originalità delle ricerche, il rigore intellettuale degli approcci e la visione estremamente moderna della medicina che caratterizzarono la sua opera di ricercatore e di clinico.
"Anticipatore con spunti originali di tante scoperte future, Moscati seppe, al tempo stesso, evitare il rischio di scomposizione dell’uomo, insito nella medicina moderna.
(…). Ma Egli seppe resistere ad un rischio ancora maggiore rappresentato da un meccanicismo che disumanizza la medicina riducendo l’uomo al suo fisicismo, escludendo la dimensione spirituale della malattia e negando che essa, al di là del suo substrato fisico, riguarda l’uomo nella sua interezza (…). Soltanto la volontà di cogliere nella sofferenza il senso che travalica il biologico, può introdurre la medicina nel mistero dell’uomo (…).
D’altra parte però, il solo accostarsi all’ammalato con sentimenti di umana solidarietà non porrebbe l’opera di Moscati al di fuori di una tradizione deontologica del pensiero occidentale che muove dalle posizioni etiche espresse nel giuramento di Ippocrate.
Se si fosse mosso in questo alveo di sentimenti e su questo registro di pensiero sarebbe stato un "medicus perfectus".
Invece fu medico santo perché intuì sempre e in ognuno la sacralità della vita, la sua intangibilità, il suo valore supremo. Fu consapevole che c’è un Dio prima e dopo la vita e che l’uomo di scienza può aiutare veramente l’umanità solo se è capace di conservare il senso della trascendenza dell’uomo sul mondo e di Dio sull’uomo.
Fu santo perché fi credente capace di trovare un fondamento trascendente per l’etica, di radicare l’agire morale ad un pensiero forte, in un Dio personale che si è fatto uomo e si è fatto crocifiggere per la salvezza del genere umano.
E questa capacità di ancorare l’agire medico ad un credo religioso è quanto mai necessaria oggi, dinanzi alle gravi problematiche morali derivanti dai progressi della medicina che scuotono profondamente le coscienze degli operatori sanitari".
Infine, il relatore ha concluso ricordando che "Moscati non è un santo solo per i medici. Egli seppe operare cristianamente in tutte le espressioni del suo agire quotidiano, e la Chiesa lo offre come esempio a tutti quanti intendono percorrere sentieri di vita cristiana nel lavoro, nella famiglia, nella società civile".
Alla fine della cerimonia ciascuno è andato via riflettendo sull’esemplarità della figura di questo medico Santo e considerando che non possiamo rimanere sordi ad una tale chiamata, se non vogliamo venir meno al nostro impegno di essere cristiani. (Autore: Maria del Rosario Steardo)
*101.10.2022/01.10.2023: Cammino Giubilare Longhiano