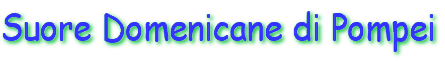1922 Sacro Cuore


*1922 Istituto "Sacro Cuore" (Pompei - NA)
Suore Domenicane Istituto Piazza Immacolata, 7 80045 Pompei (NA) "Campania" tel. 081/8633129 - 10
Fondazione dell'Istituto "Sacro Cuore"
L’ Istituto “Sacro Cuore” è tra i più grandi delle Opere pompeiane, desiderate, volute e realizzate dal Fondatore di Pompei “Bartolo Longo”, ed è stato il suo “ultimo voto”.
Vi erano assistiti circa 180 minori, suddivisi tra la Scuola Materna e la Scuola Elementare. Erano bambini dai 3 ai 13 anni, bisognosi d’affetto, di comprensione e soprattutto di cure materne.
A colmare questi vuoti vi erano Suore dedicate a questo speciale apostolato, che aiutavano gli Orfani nella loro crescita umana e spirituale.
Vi erano Suore insegnanti che curavano l’istruzione e l’educazione delle alunne; Suore assistenti che nel resto della giornata seguivano da vicino, curando, nelle minori, il senso dell’ordine, della pulizia ed educandole ad un sistema di vita disciplinata e responsabile.
Tutte le altre Suore collaboravano, con sacrificio ed amore, a rendere l’Istituto una casa calda e accogliente, proprio come voleva il Fondatore.
Pompei.Il 19 marzo 1922 fu accolta la prima figlia di madre carcerata ed il 15 ottobre dello stesso anno, Mons. Augusto Silj benediceva la posa della prima pietra della nuova Opera definita da Bartolo Longo "l'ultimo voto del mio cuore".
Il 17 dicembre del 1926, Mons. Carlo Cremonesi inaugurò l'Istituto "Sacro Cuore".
Successivamente, il Patriarca Prelato Rossi fece costruire l'attuale edificio, che fu inaugurato il 3 ottobre del 1942 e che oggi prende il nome di "Centro Educativo Sacro Cuore".
*Una nuova opera a Valle di Pompei di carità e di salvezza sociale per le figlie dei carcerati
"Fratelli e sorelle sparsi per l’Orbe, da questa Valle di Pompei che la potenza di Maria aveva già fatto salutare come la Valle dei prodigi e che la misericordia di Lei aveva fatto acclamare come la Valle della carità, sono ormai trent’anni, io levai a voi un grido, che fu come, l’erompere di una forte passione da gran tempo compressa nell’animo mio. Un grido che vi chiamava a un’Opera e a una battaglia, a un’Opera di bene e a una battaglia di fede. Un grido che era l’eco del pianto d’innumerevoli madri, e della disperata angoscia di padri infelicissimi.
Un grido che doveva dare alla libertà, negata dalla scienza positiva, una nuova apologia, alla carità cristiana un nuovo ardimento, alla fede un nuovo trionfo, all’innocenza Dio stesso: il "Voto del cuore" per un’Opera di rigenerazione e di salvezza pei più miseri, i più reietti di tutti i fanciulli, i Figli dei Carcerati.
Non era soltanto il voto del nostro cuore, il voto di questo peccatore convertito dalla divina grazia, ma era il voto del Cuore di Gesù di questo cuore che è venuto a salvare tutto ciò che era perito, che dirige le sue fiamme e le sue tenerezze là dove maggiori sono le miserie. Non era soltanto il desiderio mio, la brama che mi cruciava l’anima, che mi avvampava in un fuoco di carità per gli Orfani della Legge, ma era pure il desiderio di Maria, di Lei che è la Madre di tutti, ed in modo speciale è la Madre di coloro che non hanno madre, non hanno asilo, non hanno madre, non hanno asilo, non hanno pane, che domani potrebbero non avere Dio; di Lei che è l’Addolorata ritta non solo sotto la Croce del Calvario, ma sotto tutte le Croci dell’umanità, di Lei che predilige soprattutto l’innocenza che soffre, l’innocenza reietta.
A quel grido, il Cuore vostro, fratelli, si commosse, la generosità degli oblatori non ebbero più limiti, e l’Opera sorse; sorse non nella forma consueta, modesta, d’un Orfanotrofio, d’un Ospizio, ma nella maestà d’un monumento. Su quel monumento, ad affermazione dei nuovi trionfi della nostra fede antica, della perenne potenza sociale del Cristianesimo sempre pullulante in nuove Opere di bene, scrivemmo in cifre di bronzo una sola parola: "Charitas! – La carità!".
Ha vinto la Carità, ha vinto l’Amore; si è trionfato del pregiudizio sociale e del pregiudizio scientifico.
Mercé le nostre esperienze il "delinquente nato" è divenuto una favola della scienza, un mito ormai di tempi remoti. Si è provata, l’educabilità, in linea generale, di tutti i fanciulli, anche della prole di padri colpevoli, purché questa educazione sia fatta in speciali ambienti e con speciali metodi. Gli Orfani della Legge, divenuti i figli nostri, sono rientrati con onore alla vita, a far parte nell’esercito della patria, nell’esercito del lavoro, nell’esercito della fede, ascendendo talvolta perfino alla dignità suprema del sacerdozio.
Fratelli e benefattori sparsi per l’Orbe, istituendo l’Ospizio pei Figli dei Carcerati, noi lasciavamo non tanto per l’Opera incompleta.
Gli Orfani della Legge erano accolti a Pompei, trovavano un pane, un asilo, un padre, ma le loro sorelle? … I Figli dei Carcerati erano salvi, ma le Figlie? No, no; Dio non vuole Opere incomplete…
Possiamo noi, può la carità di Gesù Cristo abbandonare non solo nell’indigenza, ma nel fango queste creaturine, che negli stenti della loro carne e nelle impressioni della loro anima portano la miseria e la vergogna di colpe non loro?
Nessun paragone fra gli Orfanelli e le Figlie dei Carcerati. – Sono due grandi miserie, ma oh, quanto diverse! Le une, le Orfane della natura, suscitano la compassione dei parenti, degli amici, dei concittadini; le altre, cioè le Orfane della Legge, per quella esagerata solidarietà umana che accomuna i padri coi figli, destano invece un senso di ripugnanza. Per le prime tutte le tenerezze, per le seconde tutti i disgusti…
Poveri fiori! Non una mano li raccoglie, ma molti piedi li calpestano. Poveri fiori! Desideravano una luce di bene, un calore di vita, e furono invece isteriliti, furono arsi nel loro primo rigoglio da una fiamma impura, la fiamma di un esempio rovinoso dei propri genitori.
E non solo la miseria delle Figlie dei Carcerati vince quella delle Orfanelle della natura, ma supera quella medesima dei loro compagni di sventura, dei loro fanciullini, i Figli dei Carcerati.
Per esse vi può essere non solo l’abbandono, ma l’insidia, la satanica insidia degli sfruttatori di tutte le indigenze, specie poi delle indigenze infantili. Le poverine possono trovare il soccorso, ma il soccorso di uomini che fanno pagare il tozzo di pane con la peggiore forma di schiavitù, con la schiavitù del peccato.
Le Orfanelle sono un’innocenza abbandonata, i Figli dei Carcerati sono un’innocenza reietta, ma le Figlie dei carcerati sono un’innocenza in pericolo.
Queste fanciulle derelitte, affamate senza una nozione di fede, senza sentimento di Dio, spesso diventano preda di uomini che ne fanno le schiave della loro ingordigia, lo strumento della pubblica corruttela.
Se alla donna indigente manca il pane del Cielo e il pane della Carità, non le resta che il pane dell’ignominia.
Fratelli, chi sottrae all’abbandono e al vizio un Figlio di Carcerato salva un’anima sola; ma chi soccorre una Figlia di carcerato, salva tutto un numero di anime che insieme con lei potrebbero essere travolte nei vortici del vizio.
Ve lo diciamo con le lagrime agli occhi: questa è "Opera di suprema gloria di Dio" ed è insieme Opera di sapiente prevenzione di delitti e di efficace moralità sociale.
Fratelli ascoltate l’ultimo Voto del Cuore del vecchio amico vostro… Ho ottant’anni, Dio mi ha serbato sino a quest’età per vedere il compimento dell’Opera vostra per cantare il Ninc dimittis sulla prima pietra della nuova Istituzione.
Quest’Opera è per me il bagliore del tramonto, ma sarà per molte anime l’alba radiosa della rinascita. Come striscia di luce del tramonto, Dio mi ha serbato l’Opera – la maggiore fra tutte – di salvezza per le anime: a ottant’anni, sul limitare della tomba, non si pensa che alle anime e a Dio, non si guardano che le anime e il Cielo!
Fratelli, la grande crociata è aperta! Fatevi tutti soldati di questa nuova battaglia, apostoli di questa nuova idea! Il nostro motto è questo: - "alla salvezza dell’innocenza in pericolo!" Qui in questa Valle di Pompei, dove ha i suoi prodigi la fede, ma ha pure i suoi prodigi l’amore, ponete questa terza e più bella corona di Carità sulla fronte radiosa di Maria!".
(Avv. Bartolo Longo – da: Il Rosario e la Nuova Pompei, 1921, pp. 193-196)
*Salvare un innocente in pericolo è un atto di giustizia!
*Le Suore - Fiori della Carità
Singolare corona al Santuario formano gli Istituti Pompeiani. Sono i fiori della carità cresciuti alla luce della fede e della devozione a Maria e offrono una prova convincente della vitalità di Pompei. Fondati da Bartolo Longo hanno avuto uno sviluppo straordinario e sono la manifestazione della inesauribile fecondità della Chiesa e della sua ansia di elevare la condizione della vita umana a livelli sempre più alti.
Lo sanno tutti che dalla carità degli oranti a Pompei vivono le orfane della natura e della legge, gli abbandonato, i poveri, i bisognosi e per provvedere a tutti costoro si conta unicamente sulla Provvidenza.
… A Pompei, infatti, la preghiera si tramuta in carità.
Finché i genitori o i parenti non le richiedono, le orfane rimangono a spese della carità: si istruiscono, si preparano ad affrontare la vita, si dedicano con interesse ai lavori femminili e quando trovano un impiego o vanno spose lasciano l’Istituto e, lontane, il ricordo gioioso d’essere cresciute nella casa della Madonna, le anima nella loro vita.
Ma chi dedica le assidue cure ai piccoli bisognosi e alle ragazze? Chi dà ad essi calore, conforto, aiuto, incoraggiamento, amore?
Ci sono le Suore "Figlie del Rosario", volute qui a Pompei da Bartolo Longo, che incessantemente e instancabili sostituiscono in parte le mamme e seguono attimo per attimo la vita delle assistite.
Infatti, quando Bartolo Longo fondò l’Orfanotrofio pensò che per tale istituzione si richiedevano donne attente, cuori generosi, sostituti di mamme, Suore ben preparate alla loro delicata missione tra i fanciulli emarginati.
Si mise in giro per l’Italia per conoscere i migliori Istituti; studiò gli statuti e lo spirito di molte famiglie religiose e, per assicurare cure materne alle sue orfanelle, fondò una Congregazione di Suore "con statuti speciali, opportuni ai loro ministeri di carità, secondo i bisogni di questo luogo, di questo Santuario, di questo popolo" (B. Longo al Card. Mazzella).
Ottenne che tre valenti Suore Domenicane venissero ad indirizzare nei primi passi della vita religiosa il gruppo di giovani maestre e di orfanelle che sbocciavano nella luce della Madonna.
Gli Istituti Pompeiani non dovevano essere la solita opera di beneficenza cristiana a favore di un’innocenza incolpevole mediante il pane della carità, ma essi dovevano avere una grande missione: "Queste fanciulle deboli dispongono di una suprema forza, la forza dell’orazione. Il mondo dà ad esse la carità, esse in compenso danno al mondo la preghiera". (G. Auletta)
Bartolo Longo affidava perciò questi "fiori" alle Suore, fondate da Lui, perché come angeli custodi vegliassero con amore sulle vite di queste creature provate dal dolore e le aiutassero nel cammino e nella formazione di ogni giorno.
Sono tante le Suore che svolgono amorevolmente la loro opera a favore dei fanciulli e fanciulle dei nostri Istituti Pompeiani.
Esse pregano molto e guardano le Opere con gli occhi e con il cuore di Bartolo Longo: si commuovono alla vista di tanti ragazzi bisognosi e si sforzano di trasformare, come il Fondatore, tutto e tutti in un’immensa famiglia dove ci si sente sicuri, protetti, amati.
(Autore: Ermelinda Cuomo - da: Il Rosario e la Nuova Pompei - Maggio 1982)
*L'Istituto per i figli dei Carcerati